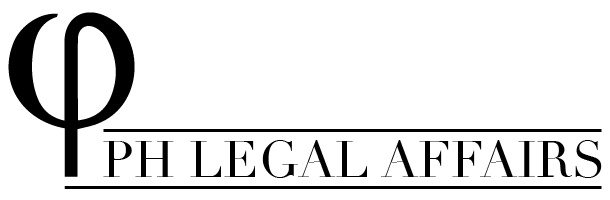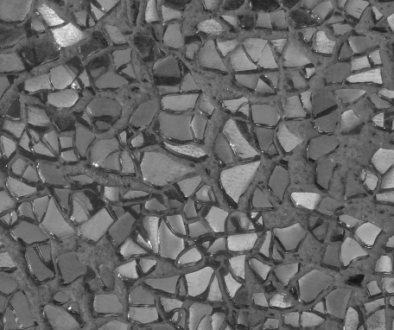La successione testamentaria
La successione testamentaria è regolata dal testamento, ossia da un atto con il quale il soggetto (de cuius) dispone del proprio patrimonio, o di parte di esso, per il tempo in cui avrà cessato di vivere.
IL TESTAMENTO
Il testamento è un atto tipico e formale, poiché è l’unico cui il nostro ordinamento riconduce gli effetti della successione ereditaria e per la cui redazione sono imposte specifiche modalità e forme, pena la sua eventuale invalidità e/o inefficacia.
È, infine, un atto sempre revocabile, atteso che al de cuius è riconosciuta la facoltà di modificare o revocare le sue ultime volontà fino al momento della sua morte.
Altra caratteristica essenziale del testamento è la sua unilateralità. Trattasi cioè di un atto proveniente da una sola persona ed il cui contenuto è riconducibile solo ed esclusivamente alla volontà della stessa.
A tal proposito, la legge vieta espressamente:
- che due o più persone possano fare testamento nello stesso atto (testamento congiuntivo);
- che due o più persone possano istituirsi reciprocamente erede nello stesso atto (testamento reciproco)
- che due o più persone possano istituire erede un terzo nello stesso atto
Alla stessa logica si ispira un altro fondamentale divieto: quello dei patti successori. Ai sensi dell’art. 458 c.c. è, infatti, da ritenersi nullo qualsiasi accordo (tra due o più persone) con il quale venga disciplinata la propria successione. Del pari, è nullo qualsiasi atto con cui si disponga (anche eventualmente rinunciandovi) dei diritti che possono spettare su una successione non ancora aperta.
Il testamento contiene, per lo più, disposizioni di natura patrimoniale, ma è possibile che per il suo tramite il de cuius rivolga ai propri eredi delle indicazioni e/o degli inviti di inclinazione puramente morale (ad es. il riconoscimento di un figlio naturale, l’invito a celebrare periodicamente una funzione religiosa commemorativa, ecc. ).
Il testamento può essere redatto da chi abbia la necessaria capacità di testare. Ne sono privi e quindi non possono validamente redigere un testamento:
- i minorenni;
- gli interdetti per infermità mentale;
- i soggetti che, sebbene non interdetti, siano stati incapaci di intendere e volere al momento della redazione del testamento.
Possono, invece, essere beneficiati da una disposizione testamentaria tutte le persone fisiche nate o concepite prima dell’apertura della successione e le persone giuridiche, quali ad esempio, enti di ricerca, di assistenza e di pubblica utilità. I destinatari delle singole disposizioni devono essere indicati con chiarezza e precisione, affinché l’individuazione sia inequivocabile (si deve, infatti, considerare nulla ogni disposizione testamentaria fatta a favore di persona incerta o di persona da nominarsi su iniziativa di un terzo).
Una volta individuati i soggetti che possono redigere testamento e quelli che ne possono essere beneficiati, non resta che analizzare le forme di testamento ammesse dalla legge, ossia il testamento pubblico, quello olografo e quello segreto.
Il testamento pubblico (art. 603 c.c.) è reso mediante dichiarazione del de cuius ricevuta da un Notaio, alla presenza di due testimoni. Il testamento pubblico verrà conservato dal Notaio sino a quando non verrà a conoscenza del decesso del testatore.
Il testamento olografo (art. 602 c.c.) è, invece, interamente scritto di pugno dal testatore, senza l’ausilio di terze persone e reca la data e la firma del testatore alla fine delle disposizioni.
Il testamento segreto deve il suo nome al fatto che il Notaio e i testimoni ignorano il contenuto delle disposizioni espresse. Detto testamento viene, infatti, consegnato dal testatore già sigillato al Notaio o viene sigillato da quest’ultimo nel momento in cui lo riceve. La consegna deve avvenire alla presenza di due testimoni. Sull’involucro che sigilla il testamento si dà atto della consegna al Notaio e della dichiarazione che si tratta di un testamento segreto. Esso può essere interamente scritto di pugno dal testatore e sottoscritto in calce, ma è valido anche se scritto da terzi o a macchina, o con il computer, purché firmato in ogni mezzo foglio.
IL CONTENUTO DEL TESTAMENTO: SUCCESSIONE A TITOLO UNIVERSALE E SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE
Al testatore è riconosciuta la facoltà di attribuire l’intero asse ereditario ad uno o più soggetti (in quest’ultimo caso la successione avverrà “per quote”: es. “lascio a Tizio, Caio e Sempronio 1/3 ciascuno di tutto il mio patrimonio”), ovvero mediante assegnazione di specifici beni (o diritti) ai singoli soggetti individuati nel testamento: nel primo caso si parla di successione a titolo universale e nel secondo di quella a titolo particolare.
Si parla di successione a titolo universale nell’ipotesi in cui il successore, che assume il nome specifico di erede, subentri, per intero o in ragione della quota assegnatagli, nella posizione giuridica del defunto, quindi non solo nella titolarità dei diritti, ma anche nel possesso dei beni, che continua nell’erede con le stesse caratteristiche del defunto, nei diritti e nei debiti, operando una confusione dei due patrimoni (fatta salva la possibilità dell’accettazione “con beneficio di inventario”).
Viceversa, la successione a titolo particolare si identifica nell’attribuzione di un legato, ossia una disposizione testamentaria con la quale il testatore attribuisce ad un soggetto un bene o un diritto determinato.
Il beneficiario di un legato è detto legatario. Quest’ultimo non subentra in una quota dell’asse ereditario, come viceversa accade per l’erede, ma acquista solo ed esclusivamente i beni e/o i diritti espressamente attribuitigli dal testatore.
La differenza principale tra erede e legatario riguarda la responsabilità del beneficiario rispetto ai debiti del defunto. Il secondo, infatti, non risponde dei debiti ereditari, salvo diversa volontà del testatore, e comunque mai oltre il limite del valore della cosa legata.
Gli eredi, subentrando in tutti i rapporti del de cuius e rispondono illimitatamente dei debiti di quest’ultimo (ciascuno in proporzione alla propria quota), salvo abbiano accettato con beneficio di inventario.
Altra differenza tra l’istituzione di erede ed il legato riguarda la modalità di acquisto. Il legatario acquista di diritto ed automaticamente il lascito (senza che sia necessario alcun esplicito atto di accettazione), ma può rifiutarlo. L’erede, viceversa, deve accettare l’eredità (formalmente o tacitamente) se intende succedere nel patrimonio del de cuius, mentre deve rifiutarla prima che sia intervenuta l’accettazione, laddove non intenda succedere al defunto.
I LIMITI DELLA VOLONTÀ DEL TESTATORE
La possibilità per il de cuius di disporre del proprio patrimonio non è, tuttavia, totalmente libera e scevra da limiti e imposizioni.
Il limite più importante è rappresentato dall’impossibilità per il testatore di escludere dalla successione alcune categorie di soggetti o di ridurre le quote di eredità loro attribuite dalla legge: trattasi dei cc.dd. “eredi legittimari”, ossia il coniuge, i figli ed i genitori del de cuius.
Gli artt. 537 c.c. e seguenti individuano le varie quote necessariamente spettanti alle richiamate categorie di legittimari (definite “quote di legittima o di riserva”), anche nelle diverse ipotesi di concorso tra loro.
La parte di patrimonio che residua dopo aver attribuito ai legittimari le rispettive quote di spettanza necessaria viene definitiva “quota disponibile”, così definita poiché il testatore può disporne liberamente, devolvendola anche a soggetti non rientranti né nella categoria degli eredi legittimari, né in quella degli eredi legittimi (ossia quelli individuati dalla legge per il caso di assenza di testamento), ad esempio amici, convivente, enti religiosi, associazioni di vario tipo, ecc.
L’AZIONE DI RIDUZIONE
Laddove il testatore non rispetti i limiti sopra indicati e con il proprio testamento abbia leso i diritti degli eredi legittimari, a questi ultima è attribuita la facoltà di esercitare l’azione di riduzione.
Legittimati attivi a promuovere tale azione contro i beneficiari delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota disponibile sono i legittimari, nonché i loro rispettivi eredi o aventi causa, i quali hannol’onere di determinare l’entità della lesione della propria quota di riserva, specificando altresì il valore della massa ereditaria e della quota di legittima stessa.
Al fine di valutare l’invocata lesione e di individuarne l’entità, pertanto, l’erede che agisce per la propria tutela dovrà prima di tutto ricostruire nel modo più corretto e dettagliato possibile l’intera massa ereditaria,” riunendo astrattamente” tutto il patrimonio attivo ed i debiti residui, nonché gli eventuali beni donati in vita dal de cuius.
Nel caso in cui si accerti la lesione della quota di legittima, si procederà alla riduzione delle disposizioni effettuate in favore dei soggetti non legittimari al fine di reintegrare quelle dei legittimari lesi, rendendo inoperanti gli effetti delle disposizioni impugnate nei confronti di questi ultimi.
Infatti, riducendo le attribuzioni effettuate agli altri, si riestende la quota attribuita all’erede legittimario leso, sino al raggiungimento delle misure minime previste dalla legge.
L’erede legittimario leso ha tempo 10 anni dall’apertura della successione per ottenere la reintegrazione della propria quota di riserva: decorso inutilmente tale termine, l’azione si intenderà prescritta.