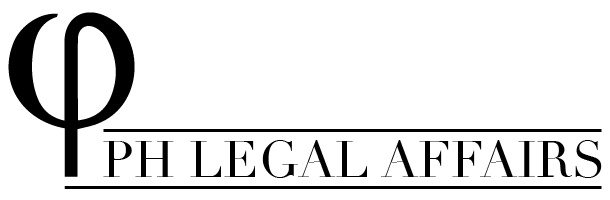Possesso dei beni ereditari e diritto di abitazione ed uso del coniuge superstite
Il chiamato all’eredità che si trovi nel possesso di alcuni dei beni ereditari è tenuto ad effettuare l’inventario della massa entro tre mesi dall’apertura della successione (o dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza), laddove intenda tenere separato il proprio patrimonio personale da quello ereditato, sì da rispondere degli eventuali crediti del defunto solo nella misura di quanto ricevuto.
Decorso tale termine senza che sia stato redatto l’inventario, il chiamato acquisirà automaticamente la qualità di erede “puro e semplice” (accettazione tacita – art. 485 c.c.), con la conseguenza che gli eventuali creditori del de cuius avranno la possibilità di aggredire l’intero suo patrimonio senza distinzioni e/o limiti (se non quelli connessi al rapporto di credito stesso).
Una posizione “speciale” è, tuttavia, riconosciuta al coniuge superstite che al momento della morte del de cuius (caso tutt’altro che raro!) si trovi a vivere nell’immobile di proprietà (per intero o per una quota) di quest’ultimo, già adibito a residenza familiare.
Al coniuge superstite, infatti, l’art. 540, secondo comma, c.p.c., riserva il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, nonché di uso sul mobilio che la correda, laddove di proprietà del defunto o comuni.
Ebbene, la giurisprudenza si è trovata a dover conciliare la coesistenza di tale ultima disposizione con quella contenuta nell’art. 485 c.c. e valutare gli effetti del possesso esercitato dal coniuge superstite sulla casa familiare e sui mobili ivi presenti.
Sul punto vi è stato un importante cambiamento di rotta da parte della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che, con la Sentenza n. 4847/2013 delle Sezioni Unite, ha superato il precedente orientamento espresso nella pronuncia n. 11018/2008.
IL PRECEDENTE ORIENTAMENTO
Secondo la pronuncia da ultima citata, l’art. 540, secondo comma, c.c. riserverebbe al coniuge superstite il diritto di abitazione e di uso del mobilio solo nell’ipotesi di successione necessaria, ossia quando si debba individuare la quota “inderogabile” per legge riconosciuta agli eredi legittimari (coniuge e figli) per tutelarla da “illegittimi sconfinamenti” di altri coeredi (ad esempio in presenza di un testamento che abbia attribuito una parte del patrimonio ereditario ad un soggetto terzo).
Nel caso di successione legittima, viceversa, non risulterebbe “…da alcuna norma che nella quota intestata in favore del coniuge superstite prevista dall’art. 581 c.c. siano compresi i diritti di abitazione e di uso…”.
Da tale presupposto, la Suprema Corte faceva discendere l’applicazione dell’art. 485 c.c. anche al caso del possesso della casa familiare e del mobilio ivi presente (di proprietà del de cuius o comune) da parte del coniuge superstite, con la conseguenza che, in mancanza della redazione dell’inventario entro il termine di tre mesi dall’apertura della successione, quest’ultimo dovesse ritenersi erede puro e semplice, avendo comportato tale possesso una forma di accettazione tacita dell’eredità.
IL NUOVO ORIENTAMENTO: LA PRONUNCIA DELLE SEZIONI UNITE
Detto orientamento, come si è detto, è stato superato dalle Sezioni Unite, che, con la Sentenza n. 4847/2013, hanno affermato l’opposto principio secondo il quale anche nella successione legittima spettino al coniuge superstite i diritti di abitazione nella casa familiare e di uso del relativo mobilio e che tali diritti configurerebbero una sorta di prelegato ex lege; con la conseguenza che il possesso attribuito al coniuge superstite in forza dei suddetti diritti non potrebbe mai condurre ad un’accettazione tacita da parte dello stesso.
L’acquisto dei menzionati diritti, infatti, non è collegato all’assunzione della qualità di erede, ma discende direttamente (in forza dell’art. 540, secondo comma, c.p.c.) dalla qualità di coniuge (superstite).
Quest’ultimo, pertanto, ben potrebbe efficacemente rinunciare all’eredità, trattenendo, tuttavia, i diritti di abitazione e di uso attribuitigli ex lege.
E SE ANCHE I FIGLI VIVONO NELLA CASA FAMILIARE DI PROPRIETÀ DEL GENITORE DEFUNTO?
La giurisprudenza della Suprema Corte sul punto ha avuto modo di precisare che il possesso esercitato sull’abitazione familiare e sul mobilio ivi presente da parte del coniuge superstite debba intendersi esclusivo ed assorbente, ossia non condiviso con i figli eventualmente coabitanti nel medesimo immobile.
Da ciò discende che non potendo i figli ritenersi possessori di un bene ereditario, bensì esclusivamente conviventi con il genitore superstite (unico possessore giuridico del bene), agli stessi (così come a quest’ultimo) non possa applicarsi la disciplina posta dall’art. 485 c.c..
Il loro permanere per oltre tre mesi dall’apertura della successione nell’abitazione che fu (in parte o per intero) di proprietà del genitore defunto non comporta accettazione tacita dell’eredità.