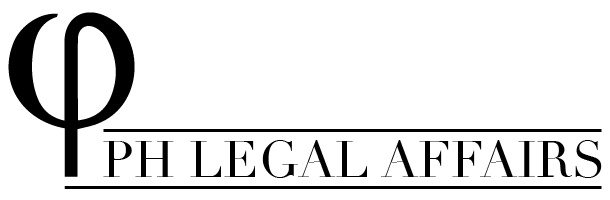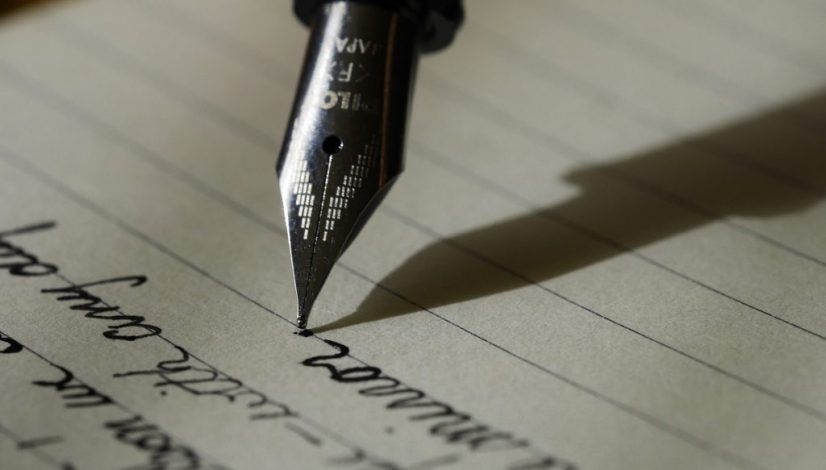Eredità: accettazione e rinuncia
L’apertura di una successione solitamente coincide con un momento di estrema debolezza emotiva dei congiunti del defunto, sconvolti per la recente perdita e “travolti” dalla burocrazia che ne consegue.
Spesso l’assenza di lucidità può condurre al compimento di scelte avventate o all’assunzione di decisioni poco consapevoli, apparentemente innocue, ma che rischiano, invece, di arrecare gravi danni ai soggetti chiamati all’eredità.
L’erede, infatti, subentra al defunto sia nell’attivo patrimoniale, sia negli eventuali debiti e, proprio per questo, in presenza di un’eredità è assolutamente necessario compiere delle attente valutazioni al fine di ricostruire (con maggiore precisione possibile) l’intera massa e verificare la convenienza di un’accettazione o di una rinuncia.
La preventiva verifica dell’esistenza di debiti ereditari e del loro plausibile ammontare è fondamentale soprattutto in considerazione del fatto che l’accettazione dell’eredità (con tutto ciò che ne consegue) può discendere anche da semplici comportamenti di fatto (c.d. accettazione tacita) ed è irrevocabile (a differenza della rinuncia).
L’ACCETTAZIONE TACITA
In base a quanto previsto nell’art. 476 c.c., si configura l’accettazione tacita dell’eredità quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe avuto diritto di fare se non nella sua qualità di erede (es. vendita o concessione in locazione con riscossione del relativo canone di un bene ereditario, esercizio di azioni giudiziarie a tutela del patrimonio del defunto, incameramento di somme di denaro presenti sul conto corrente intestato al de cuius, pagamento di debiti di quest’ultimo con denaro appartenente alla massa ereditaria, voltura catastale dei beni immobili ereditari, passaggio di proprietà dell’autovettura, ecc.).
Tali comportamenti, purtroppo, non sono specificatamente individuati dalla legge, ma sono stati, di volta in volta, identificati e descritti dalla giurisprudenza dei Tribunali di merito e della Suprema Corte di Cassazione.
È proprio nella difficoltà per il chiamato all’eredità di prevenire gli effetti di determinati suoi comportamenti che spesso si cela il rischio di accettazioni avventate.
L’accettazione tacita è, infatti, sempre “pura e semplice”, ossia l’erede subentrerà in tutti i rapporti (attivi e passivi) del defunto ed il suo patrimonio personale si unirà e si confonderà con quello ereditato, con la conseguenza che lo stesso risponderà anche con l’intero suo patrimonio personale degli eventuali debiti ereditari.
L’accettazione tacita, infine, differisce da quella espressa (art. 475 c.c.) che richiede, viceversa, un atto formale (atto pubblico o scrittura privata) che contenga la manifestazione esplicita della volontà del chiamato all’eredità di subentrare nel patrimonio del defunto, oppure la sua assunzione del titolo di erede.
Nel caso in cui nella massa ereditaria siano presenti consistenti posizioni debitorie, per evitare che l’apertura della successione rischi addirittura di arrecare danni ai chiamati all’eredità, questi hanno a disposizione due rimedi: la rinuncia all’eredità o l’accettazione con beneficio di inventario.
LA RINUNCIA ALL’EREDITÀ
La rinuncia è un atto formale con il quale il chiamato all’eredità dichiara di non volere acquistare l’eredità (art. 519 c.c.).
La dichiarazione di rinuncia può essere resa dinanzi un Notaio oppure ricevuta dal Cancelliere del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto) e deve necessariamente essere successiva all’apertura della successione (essendo nulla e completamente inefficace quella preventiva, ossia resa con riferimento ad una successione non ancora aperta).
La rinuncia non può essere parziale (ossia riguardare solo alcuni beni e non altri), né essere soggetta a condizione (ad esempio, “rinuncio all’eredità a condizione che anche Tizio vi rinunci”) o a termine (ad esempio, “rinuncio all’eredità fino al compimento della maggiore età da parte di mio figlio”). In caso contrario, essa sarà nulla e quindi non produttiva di alcun effetto.
Laddove, invece, la rinuncia fosse fatta dietro pagamento di un corrispettivo o a favore soltanto di alcuni degli altri chiamati all’eredità, essa produrrà l’esatto effetto contrario, ossia varrà come accettazione dell’eredità.
Prima di rendere la dichiarazione di rinuncia, però, è bene conoscerne gli esatti effetti.
Innanzitutto essa si estende all’intera eredità e quindi anche a tutti gli eventuali rapporti patrimoniali attivi presenti nella massa (beni, crediti, ecc).
Inoltre, in caso di eredità fra parenti in linea retta (discendenti o ascendenti), laddove il rinunciante abbia dei figli, questi ultimi subentrano al suo posto (per rappresentanza), con la conseguenza che il problema dell’esistenza di debiti nella massa ereditaria non è stato risolto, ma semplicemente traslato in capo ad altri soggetti.
Ecco che, nell’ipotesi in cui nella massa ereditaria siano presenti anche delle attività (oltre alle passività), una buona soluzione potrebbe essere rappresentata dall’accettazione con beneficio di inventario.
L’ACCETTAZIONE CON BENEFICIO D’INVENTARIO
Si tratta di una speciale modalità di accettazione espressa che consente di tenere separati i patrimoni del defunto e dell’erede, il quale risponderà dei debiti del primo solo nei limiti del valore di quanto ha ricevuto (art. 490 c.c.).
Per alcune determinate categorie di soggetti (minori, minori emancipati, interdetti, inabilitati, persone giuridiche, fondazioni, associazioni ed enti non riconosciuti) quella con beneficio d’inventario è l’unica forma di accettazione ammessa; per tutti gli altri soggetti essa rappresenta una facoltà.
Tale tipologia di accettazione si esplica in un atto formale, consistente in una dichiarazione (che può essere resa dinanzi un Notaio o ricevuta dalla Cancelleria del Tribunale del luogo dell’apertura della successione) preceduta o seguita dalla redazione dell’inventario dei beni facenti parte dell’asse ereditario.
Se il chiamato all’eredità sia già in possesso di beni ereditari, l’inventario deve essere redatto entro tre mesi dall’apertura della successione o dal momento in cui lo stesso è venuto a conoscenza di tale evento. Una volta redatto l’inventario, il chiamato all’eredità avrà poi quaranta giorni di tempo per accettare, rendendo la dichiarazione.
Laddove le attività suddette non vengano svolte nei termini richiamati, il chiamato sarà considerato erede puro e semplice e quindi risponderà degli eventuali debiti ereditari anche con tutto il proprio patrimonio.
Se, invece, il chiamato all’eredità non sia in possesso dei beni del defunto, questi potrà scegliere se prima redigere l’inventario e poi rendere la dichiarazione nei termine di 40 giorni (trascorso inutilmente il quale perderà definitivamente il diritto di accettare l’eredità) , oppure rendere la dichiarazione di accettazione beneficiata e quindi inventariare la massa ereditaria entro il termine di tre mesi, salve proroghe (trascorso inutilmente il quale, sarà considerato erede puro e semplice).
In ogni caso, il diritto di accettare un’eredità si prescrive in 10 anni.